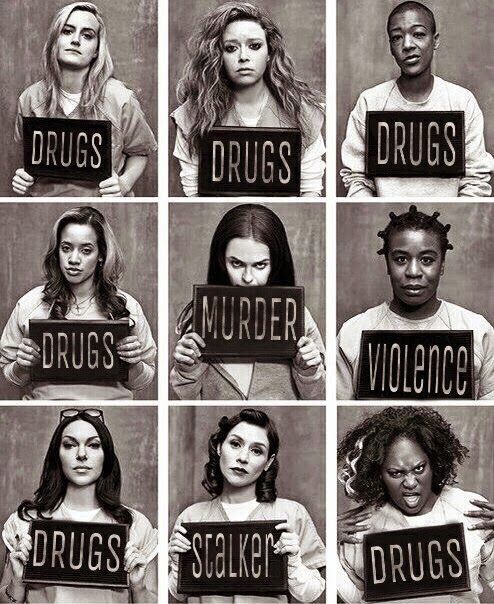«In un’azione di rovesciamento istituzionale, il rifiuto dell’istituzione potrebbe essere il primo passo comune a tutti i livelli, internati ed équipe curante».
Franca Ongaro Basaglia, 1968
Nell’episodio di novembre di Ghinea, una newsletter femminista, si accennava ad un articolo sul penitenziario femminile di Pozzuoli: Da qui il mare non si vede, ascoltare le donne del carcere di Pozzuoli, scritto da Luigi Romano e Gaia Tessitore, avvocati dell’associazione Antigone. Il carcere femminile di Pozzuoli è situato all’interno di un convento poi trasformato in manicomio giudiziario e ora – con un leggero e insignificante cambio di destinazione d’uso – un carcere. Una vera Istituzione, mal gestita, in cui ci sono poche regole di sopravvivenza: rispettare le gerarchie e non discutere.
Si scopre così che quando qualche detenuta ha qualche problema, per esempio non riesce a dormire (per l’umidità, per il riscaldamento rotto, per i rumori incessanti di sottofondo) vengono somministrati (regalati?) psicofarmaci. Benzodiazepine per risolvere problemi di gestione.
Benzodiazepine e ansiolitici sono quotidianamente somministrati in carcere, anche in mancanza di una specifica diagnosi. Alla mancanza di un percorso di sostegno psicologico, si sopperisce con la contenzione chimica continua, a bassa intensità. Molte donne ci raccontano di compresse di cui non conoscono neanche il nome, ma solo l’effetto: «Mi fa dormire». Quando chiedo se le usino anche fuori, quasi tutte dicono di no, non ne hanno fatto mai uso prima. «Ma basta che chiedi, ti danno quello che vuoi per farti stare tranquilla».
Una pillola per risolvere problemi
Questo è ciò che avviene. Si può tranquillamente chiamare contenzione chimica: non ci sono delle persone davanti, con i proprio bisogni, ma dei problemi che vengono risolti facilmente somministrando qualsiasi cosa venga in mente pur di non avere disturbo. A me questo fa schifo.
I problemi (causati da una pessima gestione) non si possono risolvere con un farmaco, non bisognerebbe nemmeno arrivare a pensarlo. Invece, viene fuori che una persona detenuta su due abusa di psicofarmaci e circa il 46% delle prescrizioni che avvengono dentro le mura del carcere riguarda psicofarmaci, soprattutto ansiolitici. Non ci si rende conto che una persona arriva in un ambiente disumano, privato di ogni suo bene, allontanato da qualsiasi relazione umana di amicizia o di amore, lanciato nel vuoto dove il tempo non passa e nessuno si occupa di lui/lei. Il supporto psicologico, come a Pozzuoli, non esiste e la soluzione è far sparire la sofferenza e il disagio – disagio che è lo Stato stesso a creare mantenendo vive queste istituzioni – riempiendo di psicofarmaci. Gli psicofarmaci non risolvono problemi, anzi è stato dimostrato che causano danni collaterali enormi: una persona che assume psicofarmaci ha un’aspettativa di vita di 15 anni inferiore alla media.
Per approfondire la questione dell’abuso degli psicofarmaci e di come siano diventati una nuova forma di contenzione, si può leggere Il manicomio chimico di Piero Cipriano.
[Per tornare sempre sul mio amato pop, sarebbe bello che nelle canzoni e nei film non si parlasse di psicofarmaci come fossero caramelle alla frutta, perché dalla mia piccola bolla sembra quasi che se dichiari di prendere ansiolitici tu sia fico: «Xananas / Vieni a rilassarti, gioia / Xananas / Ne prendo un po’ anche da sola / Xananas / Peccati di gola / Xananas / È sempre l’ora per un po’ di».]
Di cosa parliamo quando parliamo di carcere
Questa assurda situazione che si verifica a Pozzuoli e non solo, dovrebbe farci rimettere in discussione l’esistenza delle strutture carcerarie: per queste donne di Pozzuoli e per tutte quelle persone che l’Istituzione priva di dignità e di libertà.
In Italia ci sono 191 Istituzioni carcerarie. A marzo 2019 erano intrappolate al loro interno 60.512 persone – su 46 mila posti disponibili. La regione con più detenuti è la Lombardia. Le donne sono 2.659 (4,4% del totale). Di quasi 200 istituti, solo 4 sono esclusivamente femminili (di cui uno è quello di Pozzuoli). C’è una media di quattro suicidi al mese. Non sto esagerando, questi sono i dati diffusi dalla Polizia Penitenziaria.
Altri dati sono elaborati dall’associazione Antigone, che dalla fine degli anni ’80 si dedica ai diritti delle persone detenute; ogni anno redige un “rapporto sulle condizione di detenzione” – qua si può trovare l’ultimo relativo al 2018. La Corte di Strasburgo ha stabilito che bisogna garantire ad ogni persona detenuta 3 metri quadri di spazio, se questo non viene rispettato si tratta di trattamento inumano e degradante. Si scopre però che solo 16 carceri in Italia garantiscono questi tre metri quadri di spazio (lo spazio occupato da un letto matrimoniale è leggermente più grande). La Polizia penitenziaria parla di 61 suicidi, Antigone di 67 – era dal 2009 che non c’era un numero così alto: si tratta di un suicidio ogni 4/5 giorni. Anche se ce ne fosse soltanto 1 all’anno sarebbe terribile.
Questi dati dimostrano l’insostenibilità dell’Istituzione carcere.
Facciamola rotolare questa testa del re!
Qualche settimana fa, intorno ad un tavolo parlando delle REMS, ho chiesto perché non riusciamo a riconoscere il carcere come un luogo di reclusione totale, un luogo che dimostra che con la detenzione non si risolvono i problemi ma li si alimentano, un luogo in cui il soggetto che vi entra perde il suo essere un soggetto. La risposta non arriva, non riusciamo a vedere il carcere come un’istituzione che va distrutta e fatta sparire dalla faccia della terra. E non ci riusciamo mentre discutiamo all’interno degli spazi del parco San Giovanni a Trieste, quello che è stato un manicomio per quasi un secolo e che ora è stato trasformato in uno dei posti più magici che io conosca. Anzi, non stiamo nemmeno mettendo in discussione l’esistenza del carcere e ogni tanto qualcuno se ne esce con qualche frase che sottolinea la necessità della pena detentiva. Questo un po’ preoccupa. Una persona mi ha detto di leggere un testo del 1984, Tagliare ancora la testa del re (qualche frase sparsa si può trovare qua):
Dal momento in cui l’internato entra in carcere, o poco tempo dopo, non ha più importanza il suo reato né tanto meno la sua storia. Assume l’abito dell’istituzione e da quel momento l’identità del carcerato. In ordine a questa nuova identità sarà giorno per giorno visto, osservato, giudicato. Perché quel che conta è che egli sia appiattito e riconvertito in una scheggia seriale di una istituzione normativa. A nessuno interesserà più il suo reato, il suo perché. A noi sì.
Dovremmo indirizzare lì le nostre forze, i nostri pensieri, il nostro agire: dove le vulnerabilità sono maggiori. Dove ci sono delle persone in carcere, trattenute in condizioni disumane, riempite di psicofarmaci per non dar fastidio. Non possiamo avere il lusso di pensare che queste persone siano Altro da noi, che siano detenute quindi criminali quindi pericolose.
Sempre qualche settimana fa, un’altra persona ha ripreso una frase potente, can the subaltern speak?, aggiungendo altri verbi: se le subalterne non possono parlare, possono almeno ballare? Cantare? Camminare? Io mi chiedo: possono le detenute di Pozzuoli, fare una qualsiasi azione?
La risposta è no, quindi facciamo subito rotolare la testa del re perché questa risposta va cambiata.