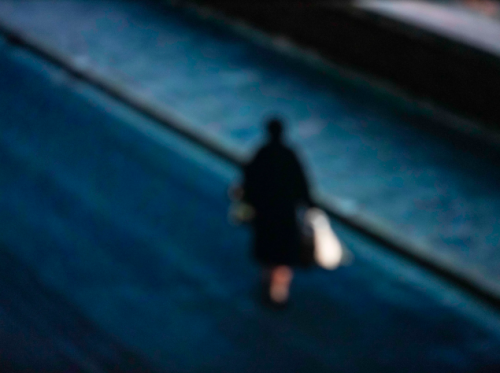 [Photograph by Valentina Sinis / VII Mentor Program / Redux]
[Photograph by Valentina Sinis / VII Mentor Program / Redux]
Di Peppe Dell’Acqua
Numerose comunicazioni estemporanee e ricerche strutturate di psicologi, psichiatri e addetti ai lavori continuano a dirci delle conseguenze del lockdown sull’umore, i sentimenti, le relazioni, in definitiva sulla salute mentale di larga parte della popolazione, tanto da poter quasi affermare che il disagio mentale è un aspetto trascurato della pandemia.
Devo confessare che tutte le volte che leggo o ascolto i pareri dei valentissimi esperti provo un senso di disagio e di riluttanza. Trovo spropositata l’attenzione dei media sulle conseguenze del virus nel campo della salute mentale, sui sentimenti, sulle relazioni, sulla normale quotidianità delle persone. Relazioni, conflitti, tristezze e malinconie che accadono da sempre, anche in assenza del virus. Mi sembra, a conferma di quanto ho sempre pensato, che ci sono psichiatrie e psicologie che sono sempre pronte a fornire le loro competenze molto qualificate, per la cura delle persone che stanno bene.
Senza trascurare la perdita di speranza, che talvolta accade, e la pena, che sento presente in me e intorno a me, credo sia opportuno limitare la già invadente medicalizzazione che sottrae ogni cosa al fluire anche ruvido della vita. È questa, a mio parere, una delle caratteristiche di quelle psichiatrie, del Manuale Diagnostico Statistico delle Malattie Mentali – ora forse in odore di una sesta edizione (!) – che sono arrivate a segnalarci più di 300 diagnosi psichiatriche. Come dire che ognuno di noi può con certezza definire nel corso della sua vita una condizione di disagio o disturbo mentale inequivocabile ed evidente.
Ecco, la correlazione salute mentale e pandemia in questi termini non mi ha mai affascinato. Credo, piuttosto, ma se ne parla poco, che le conseguenze molto drammatiche del virus sono quelle che colpiscono e aggravano la già stentata vita dentro e fuori le istituzioni delle persone che vivono l’esperienza del disturbo mentale severo, relazioni complicate, miserie relazionali e delle loro famiglie, degli operatori.
Penso alle porte che si chiudono, ai camici bianchi che ritornano, all’abbandono delle possibilità di incontro singolare e di gruppo, al trattamento farmacologico dominante, all’uso dei luoghi dedicati alla cura delle persone che vivono l’esperienza per ricoverare i malati covid, e ancora ai luoghi chiusi per matti e infetti: isolamento su isolamento. I malati di mente fanno una fatica che ancora oggi non comprendiamo a fondo, per uscire dal recinto secolare; o meglio si direbbe per riuscire a tendere lo sguardo appena fuori dalle alte mura letterali e simboliche delle istituzioni totali, dello stigma, dei luoghi comuni, e rischiano con il doppio isolamento una sempre più profonda invisibilità.
Eppure, conquiste sono state fatte, e il diritto, la cittadinanza, la singolarità, riconosciuta almeno nelle dichiarazioni dei governi in quasi tutti i paesi. Nel nostro, come nel resto del mondo, le peggiori psichiatrie, ma anche le psichiatrie pulite dell’ambulatorio, dei letti, delle cliniche, non hanno perduto l’occasione per avviare pesanti e dolorose regressioni. Parlo dei Servizi psichiatrici ospedalieri di diagnosi e cura blindati, dei Centri di salute mentale più chiusi e vuoti di quanto già non lo fossero, dell’obbligo imprevisto, ma tanto desiderato da tanti medici e da molti infermieri, di indossare finalmente il camice bianco, per giustificare ancora una volta la distanza da quell’oggetto che con fatica, sempre con fatica, cerca di presentarsi anche in tempo di epidemie con la sua storia, le sue passioni, le sue fragilità, il suo incontenibile desiderio di vita e la sua incancellabile soggettività.
Gennaio 2021




