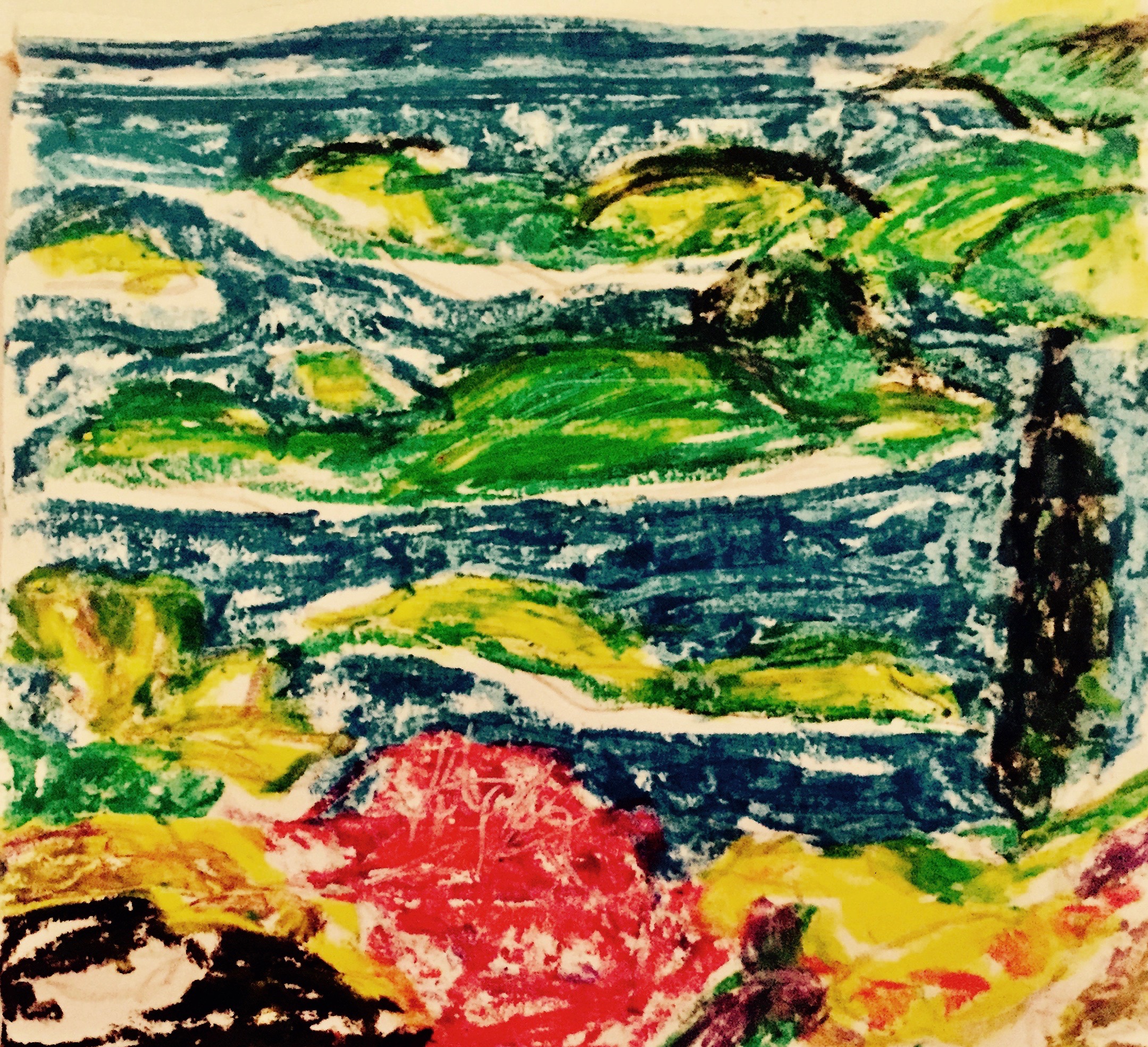di Roberto Morsucci*
Roberto Morsucci è un padre. Questo è il racconto del suo viaggio accanto al figlio, che “a quindici anni comincia a manifestare strani sintomi…”, da Roma a Trieste e poi ancora Roma. Un viaggio lungo dieci anni che ancora continua. Uno sguardo lucido sullo stato dei servizi di salute mentale, sulla distanza, che racconta enorme, della diversa capacità di accoglimento e di attenzione, fra la capitale e la città che “ovviamente non è il paradiso”, ma dove sempre al centro sono i diritti e le libertà della persona.
L’Odissea
Questa è la storia di un ritorno. Mi dispiace, non posso farla breve. Sono romano ma, come dice un famoso comico, non è colpa mia. Questo per dire che questa storia inizia nella mia citta, poi si trasferisce per dodici anni a Trieste e adesso ritorna nella capitale.
Mio figlio all’età di quindici anni comincia a manifestare strani sintomi: sente voci che non esistono ed è ossessionato dal fatto che tutti ce l’abbiano con lui, anche se non è vero. Autorizzo i lettori di questo sito ad azzardare una diagnosi. Ma quando non si hanno esperienze di salute mentale, come me allora, non ci si capisce nulla. Il mio medico di famiglia afferma che si tratta (sic) di un esaurimento nervoso che passerà da solo. Cerco uno psicologo, lo trovo e questo ritiene di poterlo curare con delle sedute. Naturalmente non succede nulla e a lui non viene neppure in mente di consigliarmi una visita psichiatrica. Finalmente consultiamo un bravo medico, un neurologo, che ci dice che non è materia sua ma che dobbiamo prenotare immediatamente una visita psichiatrica in uno dei centri di neuropsichiatria infantile della città. Aggiunge poi: “non andate dai privati che vi tolgono un sacco di soldi e non risolvono nulla”.
Ora so quanto quella piccola frase fosse un ritratto sintetico ma oggettivo della psichiatria romana. E so anche che se l’indicazione di una visita psichiatrica me l’avesse data il medico di famiglia le possibilità che i disturbi almeno regredissero sarebbe stata incomparabilmente più alta. Infatti era passato più di un anno e altri mesi, almeno sei, passeranno fino alla presa in cura di mio figlio. Una delle poche certezze condivise da tutti gli psichiatri è che se non si interviene entro due anni dalle prime manifestazione dei sintomi le possibilità di guarigione diminuiscono drasticamente.
Andiamo al centro universitario di Tor Vergata e troviamo un bravo dottore. Era ancora uno specializzando e, probabilmente, non era ancora stato corrotto dal sistema. Naturalmente c’era anche uno psichiatra che si limitava a firmare quello che gli specializzandi gli proponevano e a fare alcune visite. Dopo capirò che erano a pagamento.
Comunque mio figlio fa un day hospital ogni quindici giorni e la situazione inizia a migliorare. Poi compie diciotto anni e dovrebbe essere seguito dal CSM di zona ma lui non vuole. Gli psichiatri ci spiegano che non si può intervenire senza la sua volontà e quindi non ci provano nemmeno.
Qualche mese e ha una forte crisi. Così lo portiamo in ospedale.
Al pronto soccorso ci ospitano in una saletta solo per noi e ci viene riconosciuto un codice alto di urgenza. Il tempo passa e non viene nessuno. Dopo circa un’ora arriva un medico, un bel tipo giovanile ma che è assolutamente fuori fase. Sembra che non sappia cosa fare, si agita inutilmente, suda abbondantemente: Passano pochi minuti ed entra una dottoressa, anche lei bella e giovane, e prende in mano la situazione. Fa “calmare” il collega ed iniziano a parlare con mio figlio con buona professionalità. Lo convincono al ricovero ed ottengono facilmente il suo consenso.
L’Spdc
“Qui è come in galera: niente cinture, niente lacci delle scarpe, niente cravatte e, se ha bisogno di lamette per la barba, le consegni a noi.” Queste furono le prime parole che udimmo da un infermiere dell’Spdc. L’accoglienza era avvenuta di notte e ci avevano detto di tornare il giorno successivo. Essendo stato ricoverato in un ospedale, avevamo chiesto di cosa poteva aver bisogno e questa era la risposta che avevamo ricevuto.
Capimmo col tempo che chi ci aveva risposto in quel modo era forse il miglior infermiere, quello che tentava di fare qualcosa, di coinvolgere in qualche modo quelli che sembravano dei relitti umani e che invece erano persone imbottite di psicofarmaci, non per curarle ma semplicemente perché non dessero fastidio. Figuratevi gli altri.
Ho passato in quel reparto ospedaliero almeno due ore per ognuno dei quaranta giorni in cui è durato il ricovero di mio figlio. Eppure l’unico operatore che ha assunto una qualche fisionomia è stato quello. Gli altri non li ricordo oppure, forse, non li ho mai conosciuti. Quello era un Spdc all’avanguardia, non chiudevano gli ospiti nelle loro stanze. Erano gli operatori a chiudersi a chiave nella loro. Così che quando un ospite aveva bisogno di qualcosa, doveva bussare e fare la sua richiesta di fronte ad una porta chiusa. Talvolta quella porta si apriva. Non sempre, solo talvolta. A seconda dell’umore di chi ci stava dentro.
Che a nessuno venga in mente che gli ospiti fossero liberi di uscire dal reparto. C’era una porta ed un videocitofono attraverso il quale gli infermieri, chiusi nella loro stanza, aprivano la porta ad amici e parenti degli ospiti nelle ore di visita. E i medici, dove erano i medici? Bella domanda. Erano chiusi nelle loro stanze, fuori dal reparto. E a meno di qualche motivo specifico si guardavano bene dal mettere piede nel reparto. Non che battessero la fiacca, questo no. Ricevevano altri pazienti che curavano in “intramoenia”. Una locuzione latina con la quale si intende la possibilità per un medico che opera in ospedale di poter effettuare visite a pagamento entro il luogo di lavoro. Solo che, per legge, questa attività dovrebbe essere effettuata fuori dall’orario di lavoro. Ma chi controlla? Il primario del reparto c’era solo il lunedì mattina. L’ho visto anche in altre giornate. Mai in reparto ma sempre nelle stanze riservate ai medici, dove entravano ed uscivano persone. Erano pazienti a pagamento? Oppure amici che gli andavano a fare compagnia? Mah!
Comunque il lunedì mattina era giornata di visite. Il momento del giudizio: solo il primario poteva decidere se eri pronto per essere dimesso e c’era grande tensione fra gli ospiti. Due o tre domande, se non azzeccavi la risposta giusta, non uscivi. Ma potevi riprovare il lunedì successivo. Potete immaginare il parossismo con il quale gli ospiti aspettavano questo appuntamento.
Le visite venivano effettuate dalle dieci a mezzogiorno. Due ore. Centoventi minuti. Per una media di quattordici persone. Meno di dieci minuti a testa. Se si considera, che prima del colloquio c’era un riepilogo di cosa era successo al paziente nell’ultima settimana e solo dopo lo si ammetteva al colloquio, i minuti diventavano meno di cinque.
Ma voi vi chiederete, non ci sarà stato solo il primario ma anche altri psichiatri. Forse che loro non visitavano? No appunto, loro non visitano. Entravano nel reparto solo se chiamati dagli infermieri che si guardavano bene dal disturbarli. In quel reparto d’ospedale c’erano altri sei psichiatri e una psicologa.
Sulla psicologa non vorrei dire molto. Una sola cosa. Un giorno mi incontra sul corridoio e mi dice: “Guardi che suo figlio sta molto meglio”. Avrei voluto chiedergli su quali elementi si basava la sua affermazione. Se aveva condotto dei colloqui terapeutici, se l’aveva sottoposto a dei test. Mi limitai a chiederle se avesse parlato con mio figlio. E lei ingenuamente mi rispose: “No.” Senza aggiungere altro. Va detto che era una gran bella donna e se lo poteva permettere.
Sugli psichiatri vorrei raccontarvi i miei rapporti con loro. Non abbiate paura solo due righe per ciascuno anche perché non ci sono stati altri rapporti.
Primo. “Lei è molto preoccupato per suo figlio ma non deve. Qui suo figlio si trova benissimo.” Lo guardo con aria interrogativa e lui riprende: “Qui può fare quello che gli pare e non se lo fila nessuno”.
Secondo. “E’ passato un mese dal ricovero; mio figlio mi chiede quando potrà uscire.” “Ancora non è pronto perché non ha coscienza della sua malattia.” “Quanto tempo occorre per prendere coscienza di essere malati?” “Anni.” “Quindi?” “In ogni caso, per legge, qui non può stare per più di due mesi.”
Terza. “Senta, ho ritrovato mio figlio, il ragazzo che è scappato dal reparto. Sto cercando di convincerlo a ritornare in ospedale. Può parlarci un attimo, anche solo per rassicurarlo?” “No.”
Del quarto avrei qualcosa da raccontare ma preferisco non farlo, perché è quello che l’ha accolto al pronto soccorso e in quell’occasione si è comportato bene.
Con il quinto non ho mai parlato. Posso solo dire che una volta in giardino ho visto qualcuno che, stando in finestra, fumava in maniera concitata al ritmo di una tirata ogni due secondi. Ho pensato a qualche ospite in crisi. Ho guardato la persona. Era in camice bianco e stava nella stanza dei medici.
Il sesto, in quaranta giorni, non l’ho mai visto.
Non ho raccontato episodi scelti, ma gli unici contatti che ho avuto con i medici del reparto.
Ma forse è ora di passare al primario. Diciamolo subito a scanso di equivoci: bravo, un buon medico, preparato, ed anche un buon primario. Il lunedì mattina, quando c’era lui il reparto funzionava come un orologio. Ma, appunto, il lunedì mattina. Cosa facesse negli altri giorni lo possiamo ipotizzare ma non è dato sapere.
Posso dire che mi ha minacciato di non riaccogliere mio figlio nel suo reparto se io me lo fossi portato via senza il suo consenso.
Ed allora ho fatto quello che in Italia funzione sempre: ho messo mano al portafoglio. Gli ho chiesto se questo periodo di post-acuzie poteva essere effettuato presso una clinica privata. In questo modo io avrei potuto accompagnarlo e stare con lui.
Mi consulto con quelli di Tor Vergata e vengo indirizzata alla clinica Samadi. Dall’esterno è un bel posto in mezzo alla campagna romana. Mi rendo conto che c’è l’ossessione della sicurezza. Dovunque reticolati altissimi e telecamere a circuito chiuso. Peccato che la mattina dopo arriva prima una macchina della polizia e poi un’ambulanza senza sirene. Chiedo cosa sia successo e mi dicono che un ospite si è sentito male. Parlo con gli altri ragazzi ricoverati e loro mi spiegano che nella notte un ragazzo si era suicidato col tradizionale metodo del lenzuolo. Alla faccia della sicurezza. Comunque io mi chiedo cosa si farà di così terapeutico in quella struttura che ha un costo da hotel a cinque stelle. Dopo una decina di giorni posso affermare che l’unica terapia è quella farmacologica. Niente altro. Mi chiedo se non fosse più economico avere degli infermieri che ti portano a casa la terapia. Poi l’illuminazione: a far ricoverare i ragazzi sono soprattutto le famiglie che non li vogliono tenere a casa. Poi ci sono anche altri interessi economici ma questi li capisco dopo.
Un altro mondo
Dopo un paio di anni altalenanti di entrata ed uscita dall’ospedale, vado con la mia famiglia a passare una settimana bianca a Trento. Due soli giorni e mio figlio è nuovamente in crisi. Viene ricoverato all’ospedale di Trento anche se a me sembrava un po’ esagerata come cosa.
Così chiedo alla psichiatra se era proprio il caso di ricoverarlo. Lei mi risponde di no e che nostro figlio era stato ricoverato solo perché eravamo di Roma. A quel punto chiedo cosa sarebbe successo se noi fossimo stati di Trento e la dottoressa con il fare più naturale del mondo mi dice che se fossimo stati a Trento sarebbero stati loro a venire da noi.
A quel punto mi si è aperto un mondo. Chiedo spiegazioni a ruota libera e la dottoressa è ben contento di illustrarmi un mondo di cui non sospettavo nemmeno l’esistenza.
Tornato a Roma mi metto a ricercare i vari sistemi di salute mentali sviluppati in Italia. Alla fine escono fuori due città: Trento e Trieste. Su Trento il giudizio è unanime, è una buona struttura. Su Trieste i giudizi sono molto contrastanti. C’è chi lo esalta (soprattutto stranieri) affermando che sia il miglior sistema di salute mentale del mondo e chi lo critica e sono per lo più italiani.
A Roma tutti mi sconsigliano Trieste perché “loro non credono che esista la malattia mentale e non fanno diagnosi”, “non danno farmaci”, “sono bravi solo perché hanno molti più soldi di noi” arrivando fino ad affermare “che sono pericolosi”. L’aspetto tragico di tutte queste falsità è che questi sono medici e quindi dovrebbero avere un approccio scientifico alla realtà. Invece ci credono veramente. Altro che fake news. “Idola fori” di baconiana memoria. Attualmente si dice (lo afferma pubblicamente il presidente della SIP) che la psichiatria triestina è superata. Che ci sono nuove terapie. Se domandi quali siano, nessuno lo sa. Qualcuno biascica qualcosa di impreciso su nuovi farmaci come se gli psichiatri triestini non li conoscessero. Aveva ragione Melanie Klein. altro che il sesso, ciò che muove il mondo è l’invidia.
Torniamo a noi. Organizzo due viaggi con mia moglie e mio figlio per conoscere i sistemi di salute mentale di Trento e Trieste. Chiedo a mio figlio di scegliere e lui sceglie Trieste.
Prendo un anno di aspettativa per provare e ci trasferiamo a Trieste. Che a Trieste i sevizi pubblici funzionino bene è facile da prevedersi ma non mi aspettavo questa qualità. Il giorno dopo il trasferimento vado all’azienda sanitaria e faccio la scelta del medico di famiglia. Dieci minuti.
Non avendo altro da fare telefono al centro di salute mentale. Mi risponde un signore che mi invita a recarmi al centro. Pochi minuti e sono li. Entro e nessuno mi ferma. Nessuno ha un camice per cui non si capisce chi è ospite e chi è operatore. Poi mi verrà spiegato che il camice non si usa in quanto inutile simbolo di autorità e di distanza. Lo psichiatra, che è la persona che mi ha risposto al telefono, mi sta aspettando. Ci accomodiamo in una stanzetta e io riferisco la storia di mio figlio. Lui ascolta pazientemente e non interviene mai se non per chiedermi ulteriori particolari.
Alla fine del colloquio mi chiede quando può vedere il ragazzo. Poi si scusa perché ha un impegno il pomeriggio e quindi mi chiede se l’indomani va bene. Ho il dubbio che stia scherzando, a Roma ci sono voluti sei mesi per un primo appuntamento. Comunque dico che l’indomani andava bene. Mi risponde: “Venite voi al centro oppure veniamo noi a casa sua”. A questo punto il dubbio si fa certezza. Mi sta prendendo in giro. Tuttavia gli concedo il beneficio del dubbio e gli rispondo che saremmo venuti noi. Mi risponde: “Va bene facciamo domani alle dieci”. Lascio a voi che leggete ogni giudizio. Solo giudizi perché paragoni sono improponibili.
Trieste ovviamente non è il paradiso. Anche qui si va ondeggiando tra crisi e periodi con un migliore equilibrio. Però alcuni passi avanti si fanno. Prima aveva il terrore degli ospedali. Ora, quando è in crisi, lentamente decide lui quando essere ricoverato. Così, semplicemente. Va al CSM e gli chiede se può stare qualche giorno da loro perché non ce la fa più. Nessuno lo accompagna. Talvolta neppure ce lo dice. E’ il centro che ci avvisa telefonicamente. In dodici anni non fa neppure un TSO. Non ce n’è bisogno.
Diamo qualche numero. Nell’ultimo anno in cui stavamo a Roma mio figlio è stato in ospedale per un centinaio di giorni per una spesa complessiva sostenuta dalla regione Lazio all’incirca di 50.000 euro. Nei primi anni che siamo stati a Trieste non è mai stato ricoverato ma ha usufruito di alcune borse lavoro, sempre per un centinaio di giorni. Spesa complessiva per la regione Friuli Venezia Giulia circa 1.000 euro.
Mio figlio è cosciente di avere una serie di diritti. Sa che nessuno lo costringerà a nulla. Peraltro si sottopone a delle “trattative” infinite con i suoi medici sulle terapie. Possono durare ore e terminano solo quando il terapeuta ha raggiunto un compromesso accettabile, un accordo che stabilisca una quantità di terapia sufficiente ad ottenere l’effetto desiderato. Talvolta alla fine di questi colloqui si stipula un vero e proprio accordo scritto e firmato dalle due parti che prevede impegni reciproci.
Mi sono chiesto come facevano i medici di Trieste a trovare il tempo per queste maratone. Poi l’ho capito da solo. Se mio figlio a Roma andava continuamente in crisi, a Trieste l’intervallo fra una crisi e l’altra durava molto di più. Un colloquio di tre ore a Trieste è l’equivalente di tre colloqui di un’ora a Roma.
Gli vengono proposte delle borse lavoro sulla base dei suoi interessi e capacità. Quasi mai riesce a portarli a termine per tutto il periodo richiesto ma gli operatori del centro non demordono. Se un’esperienza è andata male, dopo un po’ se ne prova un’altra.
Qualche anno fa abbiamo raggiunto un obiettivo di una certa rilevanza: l’autonomia abitativa. Prima è andato a vivere con altri ragazzi, poi da solo in un appartamento. All’inizio aveva la compagnia di alcuni educatori poi ha cominciato a gestirsi tutto da solo. E’ un traguardo importante anche per noi genitori che sentiamo alleggerirci nella nostra quotidianità.
Questi, in estrema sintesi, i fatti importanti di un decennio su cui ci sarebbe ancora molto da raccontare.
Il ritorno
Nel frattempo ero andato in pensione e ho pensato che visto che la situazione sembrava gestibile (in pratica era solo da somministrare la terapia) noi saremmo potuti rientrare a Roma dove ci aspettavano una valanga di amici e l’altro mio figlio che mi aveva regalato uno splendido nipotino.
Ne parliamo in famiglia e siamo tutti d’accordo. Si torna a Roma. Mettiamo in vendita le nostre case a Trieste e ne compriamo due a Roma una per mio figlio e una per noi.
Ai primi di ottobre ci trasferiamo. Abbiamo comprato una piccola casa per me e per mia moglie e cerchiamo quella per mio figlio. Stiamo più stretti e mio figlio manifesta un livello crescente di ansia. Ma nonostante tutto reggiamo. Portiamo nostro figlio al Csm di zona e viene assegnato ad una dottoressa. Abbiamo una lettera del Csm di Trieste in cui viene descritta la storia, la diagnosi e la terapia seguita. Consegniamo la lettera ad una signora che sta rinchiusa in una gabbia di vetro (non è una misura anti Covid, solo difesa personale). Non sappiamo chi sia ma certo non è un medico. Questa legge la terapia e ci dice che la terapia è in dosi troppo alte e che lì, a Roma, non si usa.
Ora io non dico che se non sei medico non ti puoi permettere di criticare ma che farlo di fronte ad un paziente psichiatrico è almeno una gravissima negligenza. E poi non c’entra essere medici. Non ci vuole molto a dire che l’attuale situazione esistenziale rende la precedente terapia sbilanciata per cui si rende necessario un riequilibrio delle sostanze farmacologiche da assumere per un periodo. I medici, e non solo gli psichiatri, sono bravissimi a parlare senza farsi capire.
Mia moglie parla con la dottoressa che, dopo una prima frettolosa visita, afferma che mio figlio non può vivere in una casa da solo. A parte il fatto che sono tre anni che ha raggiunto l’autonomia abitativa e ci andrebbe spiegato perché a Trieste si può e qui a Roma no. Comunque ci consiglia di assumere un paio di educatori che dovremmo pagare noi perché “a Roma non ci sono i soldi che hanno a Trieste”. Quest’ultimo è una specie di tantra che sento da troppo tempo e con il quale si vorrebbe giustificare qualsiasi inefficienza. Il problema è che si tratta di una falsità. C’è una differenza ma è minima: a Trieste si investe per la salute mentale il 4,0% di quanto si spende in totale nella sanità. A Roma si spende il 3,8%. Nulla a che vedere ad esempio con Trento dove la percentuale arriva a circa il 7% oppure con altre regioni, per lo più meridionali, dove questa percentuale scende al 2 / 2,5% (dati del ministero della salute).
Ma è vero ci sono meno soldi. Perché? Basta leggersi il bilancio delle aziende sanitarie romane e troviamo la risposta. Oltre il 50% del budget viene usate per finanziare le cliniche private che qui nel Lazio sono numerose ed appartengono per lo più ad una famiglia che ci guadagna talmente tanto da potersi permettere di acquistare e mantenere dei giornali che sono in grave perdita finanziaria.
Solo per inciso. Non solo a Trieste ma in tutto il Friuli Venezia Giulia non c’è una sola clinica privata per pazienti psichiatrici.
Ho già espresso con chiarezza quello che so sulle cliniche private. Sono dei piccoli manicomi in cui si sta come le bestie in una gabbia dello zoo. Mi piacerebbe sapere quanti psichiatri romani che lavorano nelle strutture pubbliche arrotondano i loro guadagni offrendo consulenze a queste strutture. Ci sto lavorando.
L’incidente
Ma succede il fattaccio. Mio figlio, sotto pressione per la coesistenza familiare cui non era più abituato, senza alcun motivo apparente mi aggredisce con pugni e calci. Finiamo tutti e due al pronto soccorso. Lui per essere ricoverato nell’SPDC ed io per una frattura ad una costola.
Apriti cielo! La psichiatra lo dichiara “pericoloso per sé e per gli altri”. E’ in disaccordo con la mia decisione di non denunciarlo. Dice che se lo avessi fatto si sarebbero creati i presupposti per farlo “curare” in una REMS. Magari non subito perché, non lo sapevo, ma a Roma ci sono le liste di attesa anche per farsi sbattere in cella. Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito e la cosa più avvilente è che nessuno se ne rende conto!
Avrei voluto chiedere se ci sono liste di attesa anche per Regina Coeli che è, per antonomasia, la “galera” di Roma.
Il sistema di salute mentale romano, rispetto a quella triestino, si rivela a me come una sorta di “mondo alla rovescia”. Tra l’altro, quando mio figlio mi ha aggredito, per giustificarsi, ha detto a tutti i medici che ha incontrato che l’aveva fatto perché io lo “violentavo” da diversi anni. Questo fatto mi è stato riferito dall’ortopedico del pronto soccorso (diciamo che ingenuamente gli è scappato, così come non si è accorto che avevo una costola rotta e ci sono dovuto tornare il giorno successivo).
Nessuno psichiatra ha chiesto di parlare con me. E se l’accusa di mio figlio fosse stata vera? E comunque avrebbero potuto chiedermi qualcosa per capire da dove potesse nascere questa ostilità. Niente, sembra che io non esista. Si sono limitati a farmi sapere che non dovevo avere più rapporti con mio figlio e che se veniva a casa non avrei dovuto aprirgli la porta. Un suggerimento che mi sono ben guardato di seguire. Perché all’origini delle crisi molto spesso c’è un rifiuto. Se gli psichiatri romani non arrivano a capire che la violenza è strettamente connessa ad una frustrazione non ci posso fare niente. Eppure non ci vuole una laurea, serve solo un po’ di buonsenso.
C’è poi un altro aspetto, più subdolo, che ci viene proposto. I medici insistono che ci vorrebbe un amministratore di sostegno e io non capisco perché. A Trieste ce ne aveva uno. Non è mai servito a nulla e mi ha procurato solo noie.
Poi in un convegno sul tema a cui partecipano due associazioni di familiari romani vengo a conoscere la vera “ratio” degli amministratori di sostegno a Roma. Sono tanti ed hanno tantissimi amministrati. A parte una serie di storie sospette, sullo stile della trilogia Millenium, non si capirebbe l’insistenza degli psichiatri. Così vengo a conoscenza di strane storie nelle quali questi figuri si appropriano della volontà dei loro amministrati e danno il loro consenso ai ricoveri. Devo ancora capire come ciò possa avvenire in quanto mi sembra un procedimento illegale, ma il fatto è che nessuno controlla in quanto il tribunale non ha il personale necessario e quindi questi avvocati non presentano alcuna relazione della loro attività che, a questo punto, chiamare di “sostegno” si rischia l’indecenza.
E’ veramente un mondo alla rovescia che cancella diritti, aggira le leggi, o meglio le usa a proprio uso e consumo per nascondersi in mille beghe burocratiche che forniscono la scusa per non fare nulla o per liberarsi dei pazienti scomodi.
I triestini sono più bravi
Una domanda sorge spontanea: i medici di Trieste sono migliori di quelli romani? Dopo averci riflettuto con onestà e sforzandomi di essere imparziale posso affermare che no, non c’entra la bravura dei medici. E’ la struttura della salute mentale che è radicalmente diversa. Quando parlo di struttura intendo sia l’organizzazione sia la cultura sia le pratiche sviluppate nel tempo.
La riforma che abolisce i manicomi nasce a Trieste. Basaglia, malvisto negli ambienti accademici italiani ma ben conosciuto all’estero, compie prima un’esperienza come direttore del manicomio di Gorizia. Capisce subito che la struttura manicomiale, oltre ad impedire la conoscenza delle persone ricoverate, è un luogo dove i diritti umani, universali ed inalienabili per definizione, vengono sospesi ed ignorati. Basaglia non se la prende con le persone che ci lavorano ma con la struttura che dà forma e contenuto a qualunque azione venga effettuata. Le buone intenzioni non cambiano nulla se effettuate in un contesto sbagliato.
A Gorizia Basaglia capisce che senza l’eliminazione dei manicomi non ci può essere cura in quanto le persone che vi erano ricoverate inevitabilmente si ammalavano di “manicomio”, non vivevano più in un mondo reale ma in un universo artefatto.
Gorizia non lo accoglie bene. Il perbenismo della piccola provincia viene sconvolto e lui se ne va.
Poi c’è Trieste. Vale la pena di raccontarlo così come l’ho sentito da protagonisti di questa storia. Il direttore della provincia di Trieste, un giovane democristiano, deve nominare il nuovo direttore dell’ospedale psichiatrico. Chiede in giro per sapere chi era il migliore psichiatra italiano. Gli viene detto che il migliore era Basaglia ma che non era consigliabile e che aveva idee pericolose. Lui insiste e chiede conferma se effettivamente è lui il migliore. Soprattutto dall’estero arriva la conferma: il migliore era lui. Ed allora lo chiama e cominciano a discutere. Basaglia chiama i suoi collaboratori e dice che c’è uno più matto di lui e che gli ha dato carta bianca dimostrandosi favorevole a tutte le sue idee.
Basaglia si sceglie i suoi collaboratori e se li sceglie tutti giovani, non contaminati dalla logica manicomiale. Adesso ha le idee ben chiare, dei buoni collaboratori e un politico che gli copre le spalle e può fare la sua rivoluzione: abolire i manicomi. Come sostituirli? Il problema se lo pongono da subito perché sanno che non sarà una passeggiata. Così cominciano ad aprire l’ospedale psichiatrico alla città. Preparano il terreno per creare una rete di servizi territoriali.
Questo succede a Trieste, nel resto d’Italia viene per lo più ignorato se non deriso o comunque non preso sul serio.
Intanto si prepara il testo della legge 180 anche se le possibilità di approvazione non sono molte. I comunisti, spinti dai sindacati degli infermieri, sono piuttosto freddini, non dicono apertamente di no ma cercano delle scuse per non impegnarsi troppo. I democristiani si muovono come al solito in ordine sparso. Gli unici a sostenere la legge sono i radicali e in misura minore i socialisti.
E qui la storia, con i suoi repentini guizzi, si inserisce nella vicenda. Aldo Moro viene ucciso dalla Brigate Rosse il 13 maggio 1978. Dopo 4 giorni un Parlamento, pieno di politici distratti da questo avvenimento approva la legge Basaglia.
Poi, come sappiamo, Basaglia viene incaricato di risanare i servizi di salute mentale romani, Ma è malato, di lì a poco ci lascerà. Forse, se fosse vissuto qualche anno ancora, avrebbe potuto dare la sua impronta anche ai servizi della capitale. Forse sarebbe stato troppo difficile anche per lui. Ma ci avrebbe provato e io non starei a scrivere questo articolo per sfogare la mia amarezza.
Questi brevi appunti di storia erano necessari per capire che gli operatori psichiatrici di Trieste erano già pronti da subito ai cambiamenti, pratici e teorici, che la riforma avrebbe comportato. E da subito iniziano a sperimentare nuove pratiche coerenti con la riforma mentre nel resto dell’Italia si brancolava nel buio. Per la prima volta al mondo uno stato aboliva i manicomi. Come reagire?
A questo punto c’era il buio più fitto. Tranne che a Trieste, dove il problema se l’erano posto da tempo. La soluzione consisteva nello spostare centinaia di persone nel territorio cittadino. Ed allora è tutto un fervore di iniziative: dai centri di salute mentale ai gruppi appartamento, dalle cooperative alla richiesta di case popolari. Sono passaggi graduali ma che a Trieste sono più veloci e radicali che nel resto del paese.
C’era tutto da inventare, perché non si poteva copiare dagli altri. Se c’era una nazione più avanti, in questo senso, era l’Inghilterra e da quella nazione sono state prese delle idee ma modificandole radicalmente nel senso di evitare l’istituzionalizzazione delle nuove pratiche di cura. Un periodo difficile ma colmo di entusiasmo e fantasia. Quando sono arrivato a Trieste, trent’anni dopo quella rivoluzione sembrava che quei luoghi fossero magici dove poteva avvenire qualsiasi cosa, dove i limiti fossero aboliti. Credo che qualcuno di voi possa pensare che anch’io sia parecchio fuori di testa, io stesso lo penso talvolta. Ma il fatto è che questa impressione non l’ho provata solo io ma decine di altre persone che sono venute a visitare il parco di San Giovanni. Ma non ho paura di sembrare stupido, nulla di ciò che è umano mi è estraneo o, come dicevano i latini, “homo sum, humani nihil a me alienum puto”.
Qualche esempio
Provate invece a immedesimarvi in uno psichiatra nei primi giorni di lavoro in una struttura tradizionale dove normalmente un paziente può essere legato. Arriva un paziente in evidente stato di agitazione e di aggressività. Il giovane medico s’impaurisce ma tenta un dialogo con il paziente: non sa o meglio lo sa che il paziente percepisce la sua paura ancora prima delle parole pronunciate ma in quel momento non se ne rende conto. Il dialogo prende la forma di una schermaglia dove la punteggiatura la stabilisce il paziente. Arriva un infermiere, anch’esso mosso dalla buona intenzione di aiutare il medico che propone di somministrare un ansiolitico e di legare per un po’ il paziente così “fino a che si calma”. Ma il medico è una brava persona, un idealista, e si rende conto che legare una persona non è esattamente una bella cosa e che è suo dovere provare ancora a stabilire un rapporto. Intanto il paziente ha sentito che potrebbero legarlo e giustamente diventa ancora più nervoso.
Potrei andare avanti così all’infinito ma il finale lo indovinate già. Il giovane psichiatra, prima o poi, è probabile che decida di legare qualcuno. Fatto una volta si continuerà per sempre o meglio ogni volta che si troverà in difficoltà.
Prendiamo lo stesso medico e mettiamolo all’Spdc di Trieste. Nessuno degli operatori prende in considerazione neppure l’idea di ricorrere a qualsiasi tipo di contenzione, non solo perché esiste un regolamento che lo vieta, ma perché è “una cosa che non si fa”. Un tabù, un divieto antropologico come quello che ci impedisce di fare l’amore con un parente stretto.
Non essendo un’opzione possibile quella di legare, il giovane medico si metterà l’anima in pace sapendo che dovrà sostenere un dialogo serrato con un paziente che proverà a spaventarlo ma che in realtà è più spaventato di lui.
E’ questa, in sostanza, la differenza che c’è tra Roma (non tutta Roma) e Trieste. E’ la diversità strutturale a fare la differenza. Non la bravura o la capacità dei medici.
Tempo fa mi viene chiesto di accompagnare una delegazione che veniva dalla Lombardia per visitare i servizi triestini. C’erano operatori, medici e famigliari. Decido di iniziare dall’Spdc. Arriviamo al reparto dell’ospedale ed io, senza suonare, apro la porta. Uno dei visitatori mi si accosta e mi dice: “Ma la porta è sempre aperta?”
“Sì.”
“E non scappano?”
“No.”
“Perché?”
“Perché non possono.”
“Sono molto sedati?”
“No, semplicemente non possono scappare se la porta è aperta. Al massimo possono uscire. Si bevono un caffè e poi ritornano.”
“Perché ritornano?”
“Sempre per lo stesso motivo. Perché la porta è aperta.”
Sono sincero: mi sono molto divertito in questo dialogo surreale degno di Totò e Peppino. Al che mi sono sentito di aggiungere: “Piuttosto non vi sembra che manchi qualcosa?” Tutti si guardano intorno per vedere cosa manchi. Il salotto c’è. La televisione pure. La sala degli operatori é in ordine e perfettamente pulita. Le dotazioni di sicurezza ci sono tutte. Aspetto un po’ e poi gli chiedo. “Non vi siete accorti che non ci sono ospiti?” Si risvegliano dal torpore. “Già, come mai?” Spiego: “Le persone che hanno bisogno di un intervento urgente vengono ricoverate per la notte e la mattina sono smistate nei centri di salute mentale di pertinenza. Così che nel reparto si può mantenere il minimo del personale necessario e spostare le risorse sul territorio.”
Come vedete, anche in questo caso, non c’entra la bravura dei medici ma la progettazione di una struttura funzionale che si ispira al principio di curare sul territorio. Che è uno dei paradigmi della de-istituzionalizzazione, che è difficile da spiegare nella sua totalità ma che è di immediata comprensione di fronte ad esempi pratici.
*Roberto Morsucci, attivo nelle associazioni dei familiari